Corti, la Sorbona e un po’ di Medioevo. Un convegno internazionale celebra lo scrittore lombardo
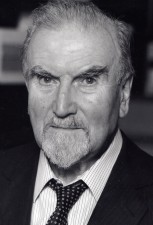
A poco più di due anni dalla morte, Eugenio Corti non smette di smuovere le acque del mondo letterario, di solito stagnanti nelle paludi di sedicenti avanguardie allineate con gli schemi di rottura dominanti. E le smuove come ha sempre fatto, ponendosi come elemento di contraddizione ingombrante e ineludibile. Il «moderno umanesimo anticristiano, figlio dell’Illuminismo», come lo ha più volte definito lui stesso, ha cercato con tutte le sue forze di ignorarlo quando era in vita, dimenticandosi momentaneamente della lezione di uno dei grandi illuministi italiani del XVIII secolo, Pietro Verri. Il quale, nell’articolo introduttivo di quel capolavoro dell’Illuminismo lombardo che fu Il Caffé, aveva avvertito che il foglio sarebbe stato pubblicato sino a quando i lettori ne avessero decretato il successo, comperandolo e, quindi, finanziandolo.
I lettori, nel caso di Corti, il successo l’hanno decretato in dimensione planetaria, rendendo possibili ben 31 edizioni del Cavallo rosso più l’e-book, contando solo quelle in italiano; a cui vanno aggiunte le traduzioni in otto lingue diverse, anch’esse in più casi con ulteriori ristampe: spagnolo, francese, inglese, romeno, lituano, olandese, giapponese, serbo. Il tutto nell’assordante reticenza massmediatica e sull’onda di un lancio affidato prevalentemente a uno spontaneo passa-parola: strategia pubblicitaria che una piccola casa editrice come la Ares ha inconsapevolmente messo in moto.
I venticinque lettori di manzoniana memoria sono così diventati centinaia di migliaia.
Strana vicenda, quella di Corti; perché proprio la patria di quell’Illuminismo da lui tanto stigmatizzato lo ha guardato con una stima che altrove gli è stata elargita con parsimonia. Sino all’evento di cui si intende parlare in queste righe: l’Université Paris-Sorbonne e l’Università Cattolica di Milano hanno realizzato un Convegno Internazionale in due sessioni, nelle due sedi rispettive, per fare il punto sugli studi relativi allo scrittore brianteo.
La prima sessione si è svolta a Parigi il 29 e il 30 gennaio 2016 col titolo Le récit par images. Eugenio Corti; la seconda è prevista a Milano per il 7 giugno prossimo.
Il bilancio dell’appuntamento parigino è decisamente positivo, a iniziare dalla statura dei partecipanti.
Tanto per intenderci, François Livi è uno dei più noti italianisti di Francia, artefice della conoscenza dello scrittore oltralpe; Cesare Cavalleri è l’editore storico di Corti, colui che per primo ne ha intuito lo spessore e ha scommesso sul suo impatto sul pubblico; Paola Scaglione è la biografa ufficiale, che meglio di ogni altro conosce i meandri della biblioteca di Eugenio, di cui è stata grande e ricambiata amica; e via dicendo.
A smuovere inopinatamente le acque, insomma, prima ancora del contenuto delle singole relazioni è stata la celebrazione stessa di questo evento: non è certamente frequente che uno scrittore contemporaneo, a soli due anni dalla scomparsa, assurga agli onori di oggetto unico di un simposio internazionale di queste dimensioni. Men che meno è usuale che un autore così dichiaratamente e polemicamente cattolico venga celebrato in un tempio della cultura laica come la Sorbona. E addirittura eccezionale è la decisione di dare così ampio risalto a uno scrittore scomodo e volutamente marginalizzato.
In poche parole: una gran bella cosa.
Proprio per questo abbiamo chiesto ad alcuni degli studiosi intervenuti di parlarci dell’argomento trattato a Parigi. Accanto a loro, Silvana Rapposelli ci ha regalato uno squarcio di “cronaca letteraria”, se così possiamo chiamarla, dal taglio inedito. Ad Alessandro Rivali abbiamo invece proposto di tornare su quelle lettere dalla Russia che sono state pubblicate solo da pochissimo e di cui ci parla anche Livi, curate dallo stesso Rivali con un titolo che fa accapponare la pelle: Io ritornerò.
Si è molto parlato al Convegno di questo titolo, tratto da un biglietto scritto ai famigliari il 9 giugno dall’allora sottotenente del trentesimo raggruppamento d’artiglieria del trentacinquesimo corpo d’armata, prima di partire per il fronte russo. «E ricordatevi: tornerò» assicura ai genitori. Di lì a qualche mese l’ufficiale si troverà impantanato con la sua Divisione, la Pasubio, nella sacca di Arbusov. Dal 20 dicembre 1942 al 16 gennaio 1943 la ritirata si fa disperata, nella totale consapevolezza di essere accerchiati. In mezzo a compagni che non dimenticherà più e che vede morire per ferite, per assideramento, per fame, per follia, la promessa fatta al padre e alla madre, tutt’altro che spavalda, suona caso mai rischiosa. E’ il rischio di chi non si affida alla sorte, ma si espone all’impegno; di chi crede nel proprio ritorno perché ha un compito da svolgere, e a questo compito dedica il dono riconosciuto dei propri giorni. Su questa consapevolezza di una gratuità ricevuta Eugenio Corti arrischia una promessa a cui si sentirà vincolato per tutta la vita: costruire il regno di Dio attraverso ciò che è capace di fare, cioè il raccontare storie.
Il Convegno ha declinato bene la realizzazione di questo intento. Oltre agli interventi che verranno riassunti qui di seguito, è stato messo a tema la descrizione del paesaggio in Corti (Rachel Monteil, Eugenio Corti poète pictural. Les natures animées); la sua visione del totalitarismo (Philippe Pichot-Bravard, Les totalitarismes dans l’oeuvre d’Eugenio Corti); il problema della traduzione (Gérard Genot ha dovuto rinunciare all’ultimo per motivi di salute ma ha promesso il suo intervento per gli Atti: Traduire Eugenio Corti).
E soprattutto, argomento che mi sta particolarmente a cuore, il rapporto di Corti col Medioevo, che Ludwine Helly ha svolto in chiave eminentemente storica e storico-letteraria (Eugenio Corti et le Moyen- Age) e la sottoscritta in chiave eminentemente estetica (Il Medioevo di Eugenio Corti: una questione di estetica).
Perché per Corti il Medioevo non è solo l’epoca “che gli piace di più”, come ha avuto occasione di dire più volte; è piuttosto un momento storico che rappresenta il modo di accostarsi alla realtà che gli è più congeniale, e che lo ha costituito come uomo e come scrittore.
Con una prospettiva di cui si può dir tutto tranne che sia ottusa o bigotta, il Medioevo è descritto come epoca in cui «la bellezza […] permeava ogni cosa»; una bellezza che ha continuato a svilupparsi e che si è poi «grandiosamente conclusa con le Madonne di Raffaello, il Cenacolo di Leonardo e la Sistina di Michelangelo», perché l’«umanesimo anticristiano» post-illuministico ha prodotto, oltre che le decine di milioni di morti del comunismo e del nazismo, «anche una colossale paralisi dell’arte in Occidente» (sono parole tratte dalle pagine iniziali del racconto Il Medioevo, pubblicato da Ares nel 2008). Quanto all’immagine opposta di un Medioevo barbaro e oscurantista che l’epoca moderna ci ha consegnato, Corti nota come quello stesso umanesimo anticristiano abbia continuato a «mettere assurdamente insieme, accorpandoli in un unico periodo, i secoli d’orrore e di miserie effettivamente prodotti dalle invasioni barbariche, coi successivi secoli dello splendido ritorno dei popoli europei alla civiltà: intendo all’antica civiltà greco-romana, riaffiorata dai conventi». Secondo Corti, quindi, i secoli della Res Publica Christiana hanno garantito la sopravvivenza dei fastigi della civiltà greco-romana e il loro sviluppo verso lo splendore rinascimentale.
Ma non è tutto. La cultura dominante spaccia i grandi progressi intervenuti in campo economico e scientifico come prodotto della modernità.
Mentre sappiamo bene – obietta Corti – che l’attuale economia di mercato fu introdotta dai grandi banchieri medievali (particolarmente abili quelli fiorentini e genovesi), e la scienza e la tecnica (entrambe di origine greco-romana) sono state recuperate e portate avanti ben prima dell’età moderna dai costruttori medievali, a cui si devono già nel Dodicesimo secolo le costruzioni arditissime in altezza – oltre che in bellezza – delle cattedrali, con tecniche ignote al tempo più antico (Il Medioevo, pp. 9-10).
Al feroce predone barbaro, sensibile solo alla forza bruta, è subentrata per gradi una figura del tutto nuova: il cavaliere medievale. […] Il cavaliere che al di sopra di tutto poneva Dio, e dopo di lui poneva […] la propria donna (la donna: quando mai nella storia si era vista, e si vedrà più in futuro una realtà simile?), il cavaliere che aveva come principi ispiratori la lealtà e la fedeltà, e considerava suo compito istituzionale combattere il male presente nel mondo […]. Certo nella pratica quotidiana egli non può essersi comportato in ogni momento così…(Ivi, p.22),
ma questo era l’ideale a cui il Medioevo si rifaceva, e che la modernità ha del tutto smarrito.
Tutto ciò fa a pezzi la svalutazione dei secoli di mezzo che decenni di storiografia di buon comando ci hanno abituati a dare acriticamente per scontata; ma fa a pezzi anche il presunto atteggiamento devozionale dello scrittore, che, come si è visto, non per motivi religiosi si proclama un fan del Medioevo, ma per motivi estetici, civili e addirittura scientifici.
Prima di tutto, però, estetici. Senza entrare qui nel merito della complessa speculazione medievale sul bello, e in particolare del rapporto tra bello e vero, va ricordato almeno che nei secoli post-classici l’asse si sposta dal ciceroniano argumentum, categoria intermedia tra historiae fabula in quanto inerente non a ciò che è realmente accaduto ma a ciò che potrebbe accadere (Rhetorica ad Herennium, I, 8, 13.), a quella tipicamente medievale di integumentum, una sorta di «corteccia litterale», come la definisce Giovanni Boccaccio, con la quale «narriamo il misterio delle cose divine e umane, sotto quella artificiosamente nascose» (Esposizioni sopra la Comedia di Dante, Esposizione allegorica, n.1).
Non, quindi, ciò che non è stato ma potrebbe essere, ma ciò che è anche se non si riesce a dire: mistero, appunto, da mysterion, a sua volta derivato da myein, chiudere le labbra per non parlare. Non è un caso che tra i propri modelli letterari Corti metta il S. Francesco del Cantico delle Creature, come spiega in una delle tante interviste riportate dalla Scaglione in Parole scolpite, edito nel 2002 dalla Ares, a p. 49: «Essendo un mistico, egli aveva conoscenza delle cose dell’Aldilà: era quindi portato a tenere sempre conto della trascendenza come, in modo infinitamente più modesto, lo sono anch’io; nello stesso tempo aveva molto forte – e pure questa è una caratteristica per cui lo sento vicino – il senso delle cose terrene, una a una». E tra i modelli mette anche l’altro mistico duecentesco Iacopone da Todi: «mi sembra che con la sua poesia abbia reso meglio dei grandi pittori e scultori il dolore della Madonna sul Cristo morto; è stato il mio principale riferimento, per esempio, nella descrizione dei campi del cannibalismo in Russia». E’ incredibile constatare quanto queste parole si avvicinino al S. Tommaso di Summa Theologiae, I, 39, a8, che per definire il bello aveva detto «Aliqua imago dicitur esse pulchra, si perfecte repraesentat rem, quamvis turpem»
Siamo sulla stessa lunghezza d’onda delle scene raccapriccianti dei racconti di guerra di Eugenio Corti, da cui i lettori non riescono a staccare gli occhi perché palesemente nascondono un Mistero, e da cui infatti si sentono innalzati, come hanno riconosciuto a decine.
Corti si muove nel punto di raccordo tra vero e bello, che il Medioevo affrontava con grande consapevolezza dell’autonomia dell’artista e, contemporaneamente, con grande rispetto del vero. L’autore fabbricava la sua opera d’arte avendo stima nel proprio operare, e quella stima gli permetteva di subordinare all’operatività di quel momento, cioè l’edificazione del suo “monumentum” artistico, ogni altro tipo di impegno culturale. Il buono e il vero erano presenti nella mente di chi operava, ma nel momento della costruzione erano “gestiti” dalle esigenze del bello.
La sintonia tra il modo di pensare il proprio lavoro e l’epoca medievale ha donato a Corti una libertà intellettuale che gli ha consentito di affermare la dignità e la necessità di una costruzione finalizzata al bello. Ma, nello stesso tempo, di rendere un servizio al vero. «Una delle soddisfazioni maggiori, nello scrivere, la provo quando riesco ad afferrare la verità e a renderla compiutamente, con forza. Per presentarla agli altri, però, è indispensabile anche la bellezza: ogni pagina deve incantare, affascinare», afferma lo scrittore nel già citato Parole scolpite, a p.52.
Sono questi alcuni dei motivi che hanno reso Corti così inattuale alla sua contemporaneità. E inattuale è stato soprattutto per la sua ricerca di ciò che va oltre il fenomenico, così distante dal modo in cui questa stessa ricerca viene portata avanti dalla modernità. Da Milan Kundera, per esempio, che nella sua Arte del romanzo sostiene che «Da quando è stata varcata da Kafka, la frontiera della inverosimiglianza è rimasta senza polizia, senza dogana, aperta per sempre. Fu un grande momento nella storia del romanzo». No, non è questo che interessa a Corti. O da Nietzsche: «Non c’è artista che tolleri il reale». No, non così per Corti, che quando narra racconta la realtà, così aderente ai fatti da essere molto spesso autobiografica. E che quando non nasce da esperienza personale, è sempre sorretta da lunghi e approfonditi studi.
Con l’avvertenza, ovviamente, che per lui il reale è la più affidabile porta di accesso alla Verità.
(Elena Landoni, maggio 2016, LineaTempo)
